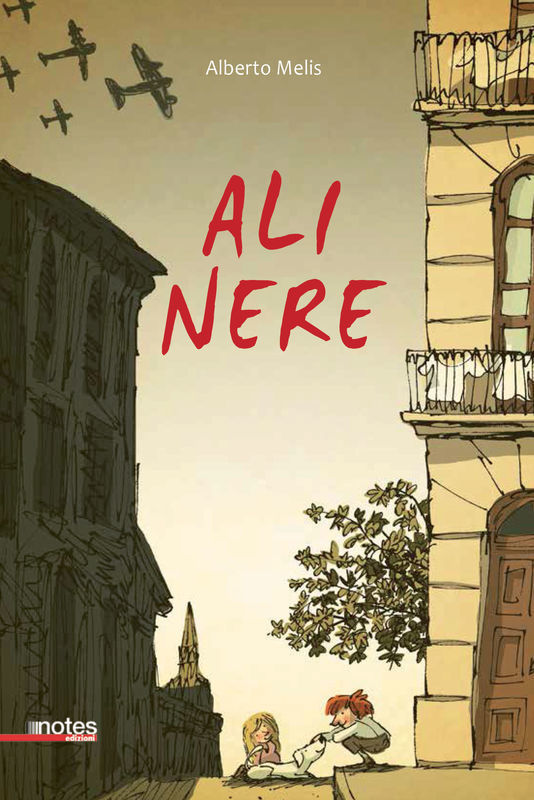|
«Ditemi
dunque il segreto, così lo porterò sulla
Terra e saremo
tutti salvi: come può un pianeta
vivere in pace?»
Kurt Vonnegut
Mattatoio n.5 o
La crociata dei bambini
--------------------------------------------------------------------
1936
In Spagna, una
parte dell’esercito guidata dal “generalissimo”
Francisco Franco
si ribella al governo
della Repubblica
e scatena un terribile conflitto che
viene chiamato Guerra Civil,
guerra civile.
Francisco Franco
intende sopprimere la democrazia
nel suo paese e
instaurare un regime fascista simile
a quelli di
Benito Mussolini e Adolf Hitler, già al
potere in Italia
e in Germania. Per questo riceve dal
dittatore
italiano e da quello tedesco molti aiuti in
armi e soldati.
In difesa della
Repubblica spagnola e della libertà
accorrono invece
decine di migliaia di volontari,
uomini e donne
comuni, provenienti da ben cinquantatré
diverse nazioni,
tra le quali gli Stati Uniti
d’America, la
Francia, l’Inghilterra, la Grecia, la
Polonia e l’Italia.
Non chiedetemi
se la storia di Tommaso e Susa che
leggerete in
queste pagine sia vera.
Io l’ho solo
scritta, così come mi è stata raccontata.
A.M.
________________________________________________
1
Anche se avessi
avuto uno specchio non avrei avuto bisogno di
usarlo. Ero sicuro che il colorito del mio viso fosse verde
smunto, come l’erba polverosa sul ciglio della
strada.
«Devi guardare
oltre il muro. Se non lo fai sei un vigliacco».
«Una carogna».
«Uno sputo di
serpe».
«E non farai mai
parte della nostra Brigata».
Continuai a
fissare i quattro ragazzi addossati al muro del
cimitero. Non la
smettevano di incitarmi. Dall’altra parte
del muro si sentirono voci che somigliavano a squittii di
topi presi in trappola. Erano uomini che
piangevano. Una voce più
alta e secca schioccò nell’aria: «Disponete questi traditori
contro la parete della cappella!»
Mi mancò il
respiro.
«Coraggio!
Guarda oltre il muro!» disse Gotzon, che era il capo
del gruppetto.
«Non lo farà»
ridacchiò uno dei compagni, un mingherlino di cui non
conoscevo il nome. «Ha il cuore di una femmina».
Gotzon mi aveva
detto che per entrare a far parte della loro
banda, o Brigata di via Kurutziaga, come la chiamavano,
avrei dovuto superare una prova di coraggio. Ma mi
infastidiva che solo io avrei dovuto guardare oltre
il muro del cimitero, dopo essermi arrampicato su
uno spuntone di roccia, mentre i quattro ragazzi
se ne stavano in basso, piegati sui talloni. Feci però quello
che mi chiedevano. Sollevai il capo
quanto bastava per vedere cosa stava succedendo. Tra
le tombe c’era un mucchio di gente. Soldati
dell’esercito repubblicano col fucile in spalla,
soprattutto. Ma anche miliziani delle Brigate Internazionali
che tenevano i loro fucili puntati su sette persone
allineate contro la parete della cappella.
Queste ultime
avevano le mani legate dietro la schiena e il
capo scoperto. Dalla posizione in cui mi trovavo potei
vedere bene il viso di uno solo di loro: era molto
giovane, con un velo di barba bionda sulle guance bianche
come il latte. Dovette
accorgersi che lo stavo osservando, perché all’improvviso voltò
il capo e mi rivolse uno sguardo umido e
disperato. Mosse le labbra
senza emettere un suono. Mi parve che
dicesse: «Mi chiamo Matìas».
« Caricate!»
gridò il comandante del plotone di esecuzione.
Mi abbassai di
nuovo dietro al muro.
«Che vi avevo
detto? È un vigliacco» ghignò il mingherlino.
«Non avere
paura, italiano!» ruggì Gotzon. «Mira! Mira la muerte
de los fascistas!».
In quel momento
vicino a noi risuonò un’altra voce. «Non guardare
invece. E voi andate via. Subito». A pochi passi
dalla roccia sulla quale mi ero arrampicato era apparsa una
ragazzina, proveniente dalle sterpaglie che
circondavano il cimitero. Al suo fianco un cane dal pelo
bianco e ispido, di dimensioni enormi. Si
rivolse ancora a Gotzon e ai suoi compagni,
che erano
schizzati in piedi come se davanti a loro fosse
comparso il diavolo.
«Ho detto
sparite» ripeté. «O volete che ordini ad Argo di
sbranarvi?».
Come se avesse
compreso le sue parole il cane ringhiò, mostrando le
zanne.
«Via… Presto…!»
Gotzon e i suoi
amici si lanciarono tra le sterpaglie.
«Puntate!» gridò
il comandante del plotone.
Mi inginocchiai
sulla roccia e coprii le orecchie con le mani.
«Fuoco!»
Il crepitare
degli spari fu come il rullio delle bacchette su un tamburo.
Guardai di nuovo dentro il cimitero. I
sette uomini erano stesi a terra. Al più giovane,
un po’ distante dagli altri, come se all’ultimo
momento avesse tentato di fuggire, erano sbocciati sulla
schiena tre fiori rossi di sangue.
Mi chiesi se
davvero si chiamasse Matìas.
Scesi dalla
roccia, mi inginocchiai a terra e vomitai. Quando riuscii a
smettere e mi sollevai per riprendere fiato, mi
accorsi che la ragazzina e il suo cane erano ancora lì. Aveva i capelli
neri corti e la gonna annodata tra le gambe magre, in
alto, sin quasi all’inguine, così che
sembrava
indossasse un paio di pantaloni. Ai piedi un paio di
malconci scarponi da montagna.
«Te l’avevo
detto di non guardare » mi rimproverò.
«Io mi chiamo
Susa».
«Io Tommaso…
Tomi».
«Immagino che
avrai già sentito parlare di me, vero?»
Annuii senza
riuscire a staccare gli occhi dai suoi, che erano di due
colori diversi. Uno verde muschio, vivido e scuro;
l’altro di un azzurro tenue, come a volte è il cielo
dopo una pioggia intensa. «Ti ho vista al
mercato, la settimana scorsa» mormorai.
«Ti sei sporcato
la giacca e la camicia» disse ancora lei. «Seguimi,
ti aiuterò a ripulirti. Se non hai paura di me».
Sollevai le
spalle. Non avevo paura di lei, a differenza di quel
vigliacco di Gotzon.
Continuavo
invece a tremare per ciò che stava succedendo dentro il
cimitero.
«Caricate!»
tuonò di nuovo la voce oltre il muro.
«Andiamo via, ti
prego» sussurrai.
Seguii la
ragazzina e il suo cane, domandandomi cosa avrebbero
detto al mio ritorno Antton ed Elaia, i due anziani
contadini che avevano accolto me e mio padre Arturo
nella loro casa di Durango, pochi mesi dopo l’inizio
della Guerra Civil. Entrambi si
sarebbero preoccupati moltissimo, se avessero saputo
cosa ero andato a fare al cimitero, in compagnia di
Gotzon e dei suoi amici. Ma forse si sarebbero
preoccupati ancora di più sapendo che avevo deciso di
seguire chissà dove Susa, di cui molti a Durango
parlavano a mezza voce, perché credevano che fosse una sorguin,
una ragazzina mezzo strega e mezzo
fata.
Man mano che ci
allontanavamo, avvertii altre scariche di moschetti.
Dopo i terribili avvenimenti accaduti il giorno prima
nel centro abitato, la ritorsione sui fascistas
non aveva fine. Era stato il
vecchio Antton a raccontare a me e a sua moglie Elaja ciò
che era accaduto il giorno prima nello slargo di
viale Ezkurdi. Antton era
tornato a casa trafelato, stringendo in
mano un
pacchetto. Era evidente che non vedeva l’ora di
raccontarci cosa aveva visto, ma prima aveva consegnato il
pacchetto ad Elaja.
«Sono le
medicine per il valoroso capitano Serra».
Quando Antton
parlava di mio padre, diceva sempre così: “il
valoroso capitano Serra”. Quindi mi aveva
rivolto lo stesso sguardo tenero che avrebbe
potuto rivolgermi uno dei miei nonni che vivevano in
Italia, se solo avessi avuto la fortuna di conoscerli, e
mi aveva chiesto: «Come sta tuo padre oggi?»
«Come ieri»
avevo risposto. «Dorme. Dorme sempre. Ma non si
lamenta».
«Speriamo che
queste nuove medicine possano aiutarlo » era intervenuta
Elaja, anche se con un tono di voce poco
convinto.
Nessuno dei
medici che avevano visitato mio padre dopo il suo
arrivo a Durango era riuscito a darsi una spiegazione
del suo stato di salute. Aveva una ferita al fianco
e una alla tempia destra, che si era procurate nella
battaglia di Monte Pelato. Ma visto che non si
trattava di ferite particolarmente gravi, il comando della
sua formazione militare, invece di inviarlo in un
ospedale di Barcellona, aveva dato disposizioni
perché venisse trasportato a Durango, un popoloso
villaggio della Biscaglia dove avrebbe potuto ricevere
le cure necessarie e trascorrere la convalescenza. Quando, però, io
e mia madre Annita l’avevamo finalmente
raggiunto dopo aver lasciato la nostra casa a Madrid, l’avevamo
trovato in uno stato d’incoscienza di cui nessuno
sapeva spiegarsi le ragioni. Mio padre
Arturo, il valoroso capitano Serra, non aveva brividi di
freddo, né convulsioni, né febbre alta provocata
da qualche misteriosa infezione. Semplicemente
dormiva, immobile, lontano da tutto, senza mai un
lamento.
«Dobbiamo
portarlo via da qui» aveva detto mia madre. «Via
anche dalla Spagna. In Francia. A Parigi ci sono ottimi
ospedali e medici eccellenti che forse potranno
farlo guarire. Ma non sarà facile organizzare il trasporto».
Quando avevo
capito che mia madre intendeva partire per
trovare l’aiuto che le occorreva, l’avevo supplicata di
portarmi con sé, ma lei era stata irremovibile. «Tornerò a
prendere te e tuo padre il prima possibile» aveva detto. Mi aveva stretto
in un abbraccio forte e deciso. «Ricorda… Non
piangere! Noi non piangiamo» mi aveva soffiato
all’orecchio.
Dopo che lei era
andata via, avevo lasciato che Elaja mi facesse
sedere sulle sue ginocchia. La donna mi aveva tenuto stretto
a sé e io non avevo pianto, anche se avevo una
gran voglia di farlo. «Vedrai, tua
madre tornerà entro pochi giorni» aveva detto Antton. Ma
di giorni ne erano già passati parecchi, e di
mia madre Annita non avevamo avuto più nessuna
notizia.
«Allora, cosa è
successo nello slargo di viale Ezkurdi? » aveva chiesto
Elaja a suo marito, dopo aver preso le
medicine per mio padre.
«Avete sentito
le esplosioni?»
«Sì. Due».
«No, almeno tre»
l’avevo corretta io.
«Giuro che non
capisco» aveva sussurrato allora Antton. Ci aveva fatto
sedere vicino a lui e aveva tracciato col dito un
cerchio immaginario sul tavolo. «Oggi nello
slargo del viale Ezkurdi un gruppo di ragazzi giocava
alla pelota. Alle undici in punto si è sentito il rombo
di un aereo. Tutti hanno smesso di giocare». Antton aveva
continuato a parlare con voce incredula. Sopra Durango
erano apparsi due velivoli. Si rano abbassati
sin quasi a sfiorare i tetti delle case e poi avevano
lasciato cadere alcune bombe. Una era caduta sulla
stazione. Una era finita nel giardino del dottor
Unamunzaga. La terza, infine, era precipitata sui ragazzi che
sino a un istante prima giocavano alla pelota. Tra di loro c’erano
stati dodici morti.
«Cosa non
capisci?» aveva chiesto Elaja ad Anton.
«Non capisco
perché quell’aereo dei fascistas ha sganciato le
bombe sul nostro centro abitato». Era indignato.
«Forse è stato uno sbaglio. Perché in guerra un
esercito colpisce l’esercito nemico. In campo aperto. È
sempre andata così! Non dei ragazzi disarmati che
giocano alla pelota!»
Avevo avvertito
una stretta alla bocca dello stomaco.
«Che c’è
ancora?»
Elaja si era
accorta che Antton aveva altro da dirci. «Domani farete
meglio a non uscire di casa».
«Perché?»
«Pare che gli
amici e i parenti dei ragazzi uccisi, insieme ai miliziani del
Battaglione della Gioventù, vogliano
pareggiare i conti per ciò che è successo oggi. La gente
dice che domani andranno al Carcere Municipale, dove
sono stati rinchiusi i prigionieri fascisti. Li
tireranno fuori e poi li porteranno al cimitero, dove li
fucileranno».
Elaja aveva
sgranato gli occhi. «Ma non sono stati loro a sganciare
quelle bombe! Sarebbe una vendetta!»
«Ho paura che
niente potrà impedirlo» ribatté Antton mestamente. «Il
pilota che ha sganciato quelle bombe è un loro
complice».
Quella notte non
avevo chiuso occhio. In parte perché ero rimasto a
lungo nella camera di mio padre, con la sua mano
stretta tra le mie, e in parte perché quando mi ero
infilato sotto le coperte non avevo fatto altro che
pensare a quello che avevo sentito.
L’indomani
mattina, invece di seguire il suo consiglio, ero sgattaiolato
fuori di casa e avevo incontrato Gotzon e i suoi
amici, che mi avevano chiesto se volevo entrare a
far parte della loro Brigata. Mi avevano
assicurato di aver messo da parte, in un nascondiglio
segreto, fucili, pistole e bombe a mano di legno del
tutto simili a quelle vere che usavano i soldati.
Insieme a diverse fionde e una maschera antigas a cui
mancava solo il filtro per funzionare.
Non era stato,
però, per poter ammirare ciò che per Gotzon e i suoi
amici era un vero tesoro, che avevo deciso di
affrontare la prova di coraggio che mi avevano chiesto.
La verità era
che intendevo guardare in faccia i prigionieri che sarebbero
stati portati al cimitero. Mi illudevo che tra
loro potesse esserci anche il soldato fascista che a
Monte Pelato aveva ferito mio padre. E che, forse,
per istinto, sarei riuscito a individuare il suo sguardo torvo,
carico di ogni inumana ferocia.
Non potevo certo
immaginare che l’unico nemico che sarei
riuscito a guardare in viso, invece, sarebbe stato un ragazzo
che forse si chiamava Matìas, conappena un velo
di barba bionda sul viso pallido e due occhioni pieni di
paura.
|